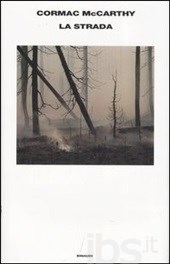
Catastrofe nucleare. La Terra è diventata un inferno. Scomparsi tutti gli organismi animali e vegetali. Solo qualche uomo è sopravvissuto. Lotta per la vita: mors tua vita mea.
In questo deserto, un cielo plumbeo sopra la testa, un uomo e suo figlio viaggiano verso sud in cerca di un clima più mite e un posto dove, forse, la vita non sia scomparsa del tutto.
Poche le parole scambiate con altri umani. Il dialogo continuo è quello tra il bambino e suo padre. Il bambino ha paura, sa poche cose ma ha uno spiccato senso morale. L’uomo è più diffidente e feroce: deve innanzi tutto salvare suo figlio.
Il linguaggio è diventato essenziale. Il bambino ricorda brandelli di conversazione del passato (“quali sono i nostri obiettivi a lungo termine?” oppure “le probabilità non sono a loro favore?”) e il padre sorride perché questi discorsi più strutturati hanno perso di significato.
Ma rimane il quesito di fondo (la bellezza del libro è qui): noi siamo i buoni? esistono ancora i buoni? Il padre non fa morire la speranza e il bambino, quando capisce che il padre sta morendo, si rende conto che ora tocca a lui andare avanti e avere speranza nel futuro (portare il fuoco).
Il libro si presta a una riflessione sulla “parola”.
Fin dalla nascita noi siamo immersi in un sistema culturale ricco di relazioni che si esplicano soprattutto attraverso il linguaggio. La realtà stessa che ci circonda vive attraverso il nome con cui la rappresentiamo. Il linguaggio è sinonimo di mondo. Se muore il mondo noi perdiamo le parole che ci servono a rappresentarlo e, perdendo queste, perdiamo la nostra umanità.
Nel mondo descritto dal libro l’uomo è regredito allo stadio animale, ma un bambino che guarda al futuro ha bisogno delle parole, per distinguere i buoni dai cattivi e per immaginare una realtà diversa in cui esista un sistema di parole più complesso con cui si valuta, si ragiona, si spera. Occorre qualcuno che riporti agli altri umani il fuoco, come un novello Prometeo.
Carmen